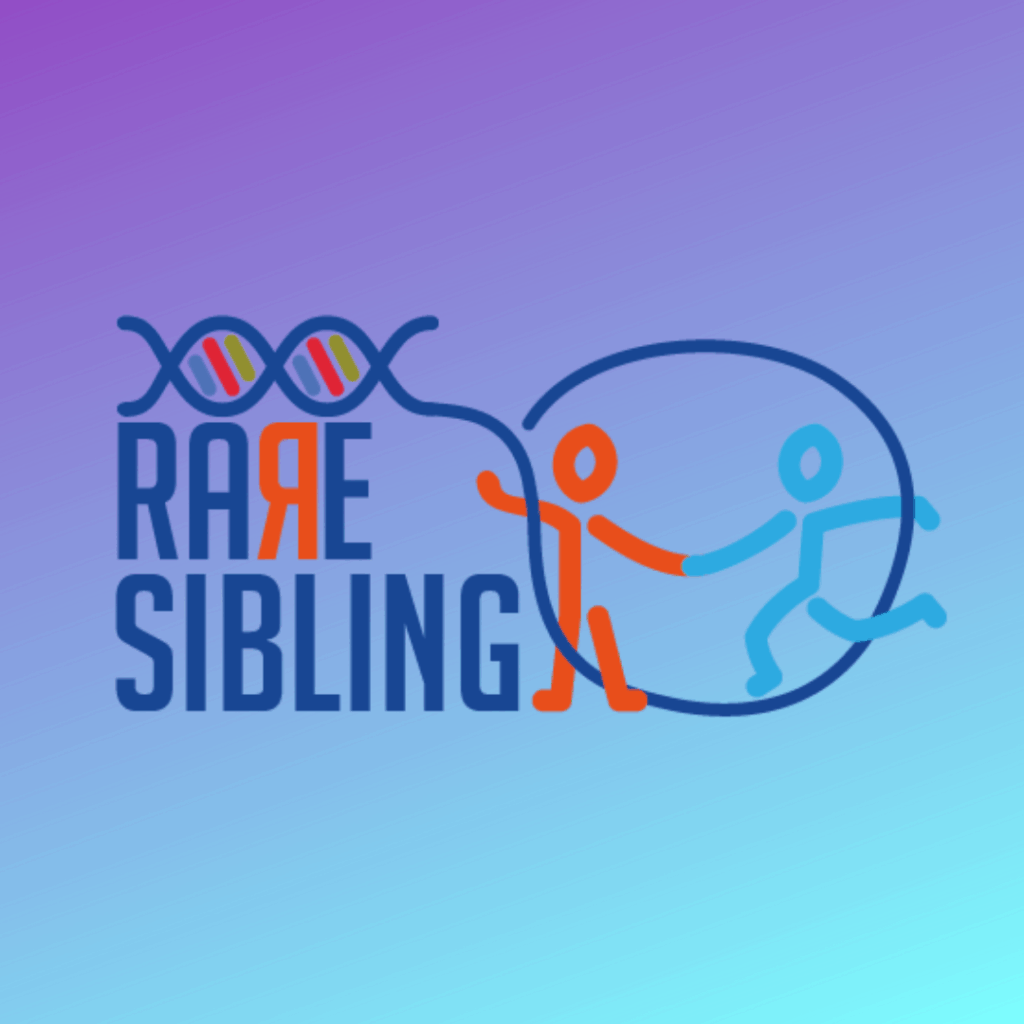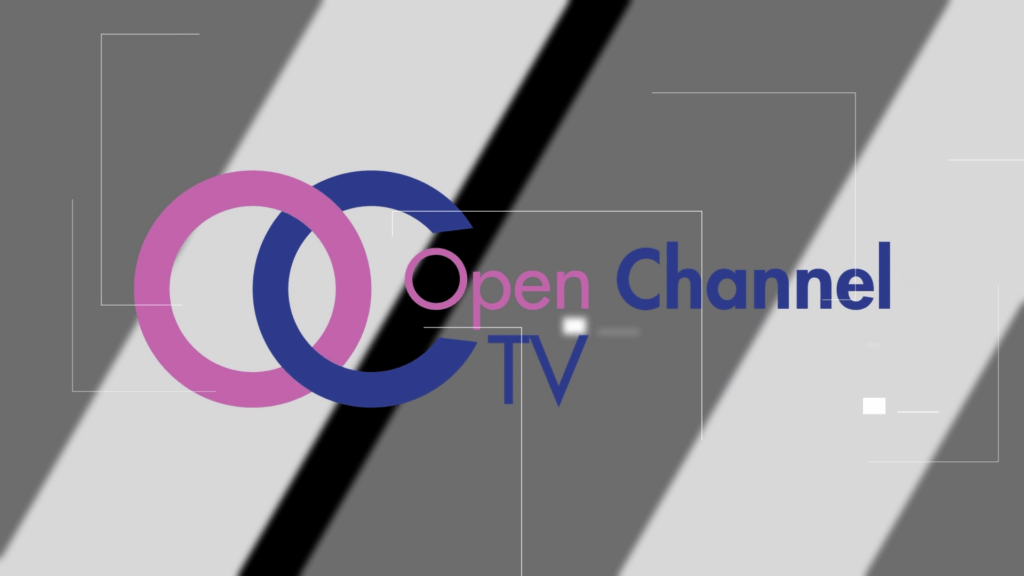La presentazione del libro “Rompere il gioco” di Fabrizio Acanfora (edito da Effequ) al Salone del Libro di Torino ha analizzato l’attivismo all’epoca dei social network. In un contesto dominato dalla comunicazione performativa e dalla necessità di “funzionare” per l’algoritmo, Acanfora ha riportato il discorso su un terreno più umano, vulnerabile, ma anche radicalmente politico.
Per Acanfora, ricercatore, docente universitario, scrittore, musicista, divulgatore e attivista autistico, essere presente fisicamente a un evento così affollato e rumoroso è già di per sé un atto di coraggio e di militanza: «Il rumore dell’aria condizionata, la gente che urla… già essere qui è un successo» ha scherzato (ma non troppo). Un modo per riconoscere come l’uscita dalla comfort zone possa essere, in certi casi, non solo una sfida personale ma anche un atto di trasformazione collettiva.
L’attivismo come rottura del sistema
Il titolo del libro non è casuale. Rompere il gioco significa mettere in discussione le regole non scritte che governano le nostre relazioni, i nostri modi di comunicare, perfino il nostro modo di fare attivismo: «Per farsi sentire bisogna essere scassacazzi» ha detto Acanfora citando suo zio che così lo apostrofava da bambino, e aggiungendo con tono meno ironico: «Fin da piccolo mi dicevano che ero polemico, pensavano che avrei fatto l’avvocato».
Nel libro, e nel suo intervento, Acanfora ha smontato l’idea di un attivismo perfettamente incastonato nei meccanismi dei social media: strumenti nati per il mercato, dove la visibilità è regolata da algoritmi, competizione e branding personale: «Fare attivismo con strumenti pensati per vendere – ha proseguito – è controproducente: è un modello di aggregazione freddo e individualista, che rischia di trasformare la lotta collettiva in una gara a chi ha più follower».
Social media: rete o vetrina?
Un punto centrale della riflessione è il ruolo dei social. Acanfora ha iniziato a usarli “da grande”, riconoscendone l’utilità, ma anche i limiti: «I social media spingono alla personalizzazione estrema, a diventare solisti dell’attivismo. Anche chi fa attivismo sulla disabilità è spinto alla competizione, guardando ai numeri prima di ogni collaborazione» ha poi aggiunto. Il problema non è internet in sé, ma l’architettura commerciale delle piattaforme.
Non è un caso che molte persone con disabilità abbiano trovato grazie alla rete una forma di partecipazione prima impensabile. Ma affinché diventi reale attivismo, serve qualcosa di più: collettività, organizzazione, pressione politica: «Le petizioni online e le condivisioni vanno bene, ma se non si trasformano in azioni collettive restano monologhi digitali» ha sottolineato.
Dall’inclusione all’autodeterminazione
Acanfora ha anche criticato il concetto di inclusione, troppo spesso vissuto come una concessione dall’alto: «Prima ti escludo, poi ti includo: chi ha questo potere? In quali condizioni? È un gesto verticale che mantiene la dipendenza. L’inclusione, per come viene intesa nel linguaggio dominante, è ancora parte del gioco che va rotto: serve un ribaltamento, non vogliamo essere inclusi ma vogliamo autodeterminarci» ha proseguito.
Il rischio dell’attivismo performativo
Il rischio maggiore, per Acanfora, è che l’attivismo venga inglobato dalle stesse logiche contro cui nasce: «Oggi è difficile anche solo esprimere dissenso. L’attivismo viene criminalizzato, accostato al terrorismo. Sui media e nei discorsi pubblici domina l’idea che “non si possa più dire nulla”». Questo è l’effetto di un linguaggio politico sempre più depoliticizzato, dove anche la sinistra ha perso il contatto con le lotte di classe per abbracciare un discorso più vicino al neoliberismo.
La critica si estende anche al “brand activism”, come nel caso delle aziende che sponsorizzano il Pride: «Dobbiamo immaginare alternative, non solo cercare spazio dentro il sistema. Rompere il gioco vuol dire guardare oltre, riappropriarci della possibilità di immaginare altri modelli».
Ricostruire il collettivo
Nel suo intervento al Salone, Acanfora ha infine lanciato un appello alla collaborazione reale e concreta. «Se c’è un tema che ci interessa, dobbiamo cercare un gruppo, metterci insieme, fare rete, creare pressione politica, andare alle manifestazioni». In un’epoca in cui anche le giornate mondiali sono diventate eventi da performare sui social, l’autore ci invita a rallentare, riflettere e uscire dal loop dell’iperproduttività digitale: «Se pubblico un articolo ben pensato una volta al mese, ottengo meno visibilità rispetto a chi pubblica contenuti ogni ora, ma forse è quello il punto: costruire pensiero, non performance» ha concluso.
Guardare oltre
“Rompere il gioco” è un invito forte a uscire dalle logiche dell’inclusione paternalistica, del branding attivista e del marketing politico. Un richiamo a tornare all’azione collettiva, al pensiero critico e all’immaginazione radicale. Perché, come ha ricordato Acanfora, «non sappiamo se riusciremo a rompere il sistema, ma possiamo almeno provare a riformarlo, guardando oltre».